Memoria di M.
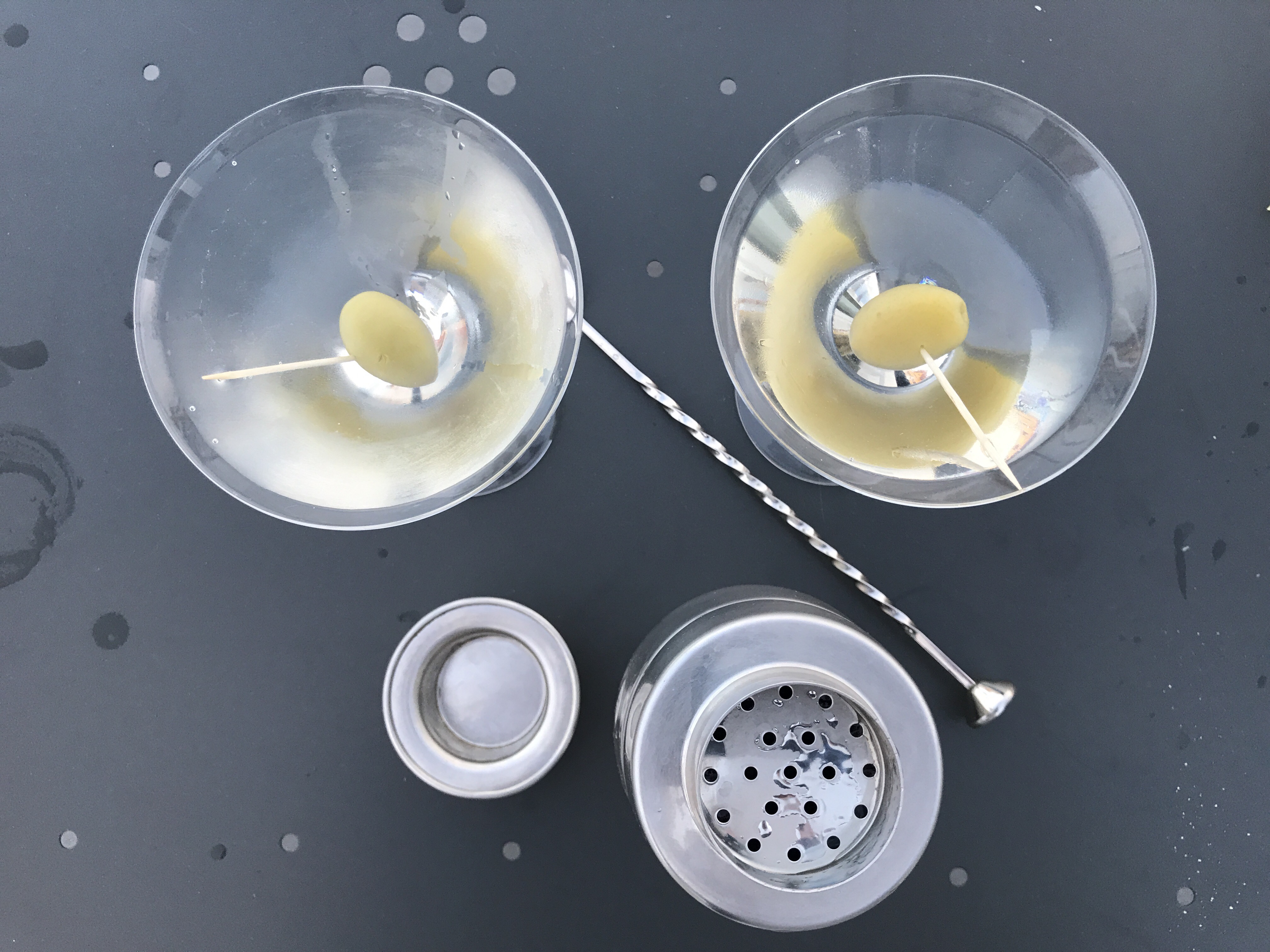 La mia tata era la mamma che non ho mai avuto.
La mia tata era la mamma che non ho mai avuto.
Lo sapevo io. Lo sapeva lei. Non ce lo siamo mai detto. Perché non stava bene e io una madre ce l’ho.
La mia tata era un gesto veloce e furbo, due mani forti di rughe e di sogni, occhi color dell’ombra fra i castagni. Profondi. Generosi.
Non aveva tante parole.
Non teneva nulla della sua paga. Erano soldi d’altri, che servivano ai mille bisogni di una famiglia che teneva insieme con la pazienza dell’amore. Solo uno spicciolo rubava alla sua paga prima di salire sulla corriera e tornare. Un gratta e vinci perché la mia tata aveva un sogno, avrebbe voluto aprire una lavanderia. Solo essere finalmente padrona del suo tempo.
La mia tata si è spenta nel suo letto. Piano perché non voleva morire. Si è spenta quando ha capito che ormai le sue mani non erano più utili, quando si è resa conto di non poter più tagliare due fette di pane per regalare una merenda e un sorriso di castagne.
Le è morto il sorriso e si è fatta piccola nel pigiama felpato d’ospedale, perché il suo posto non era fra le malattie e i malati che parlano solo del loro dolore come un naufrago può parlare dell’abbraccio di uno scoglio.
Il suo posto era fra i bambini in un canto di fiume fra la strada e l’orto.
Quel canto in cui sono stato solo una volta per piangere con lei un composto addio per un amore durato tutta una vita e adesso devo tornare.
