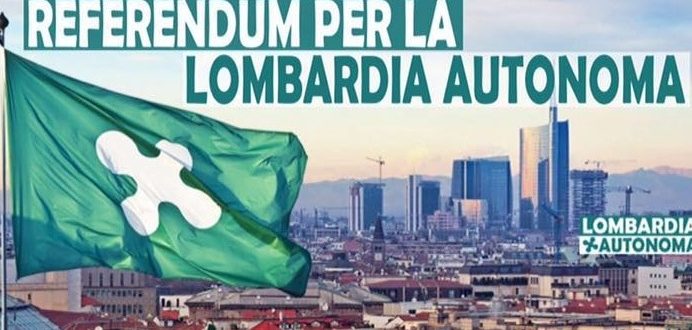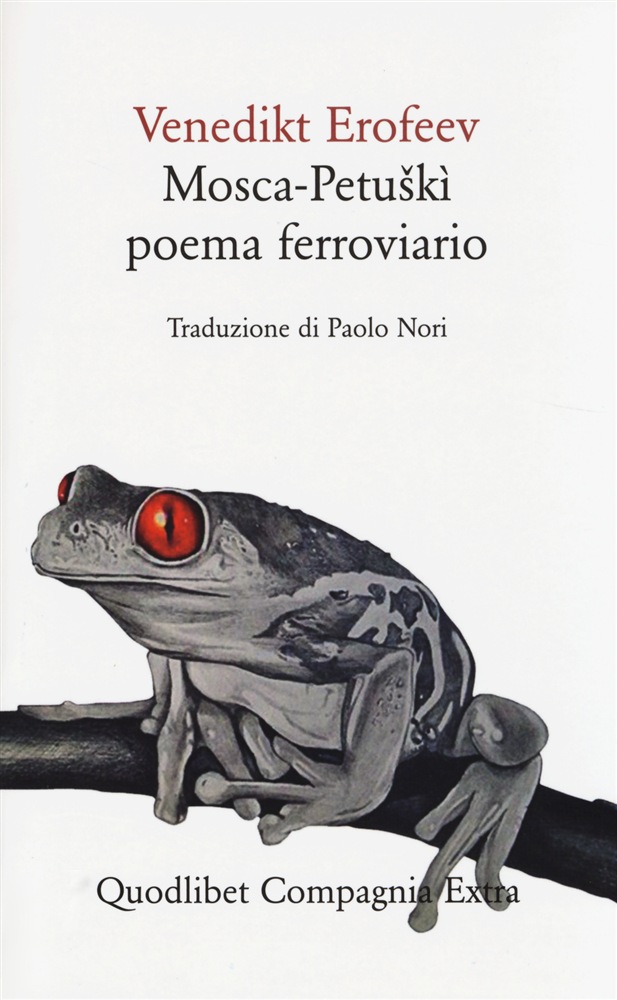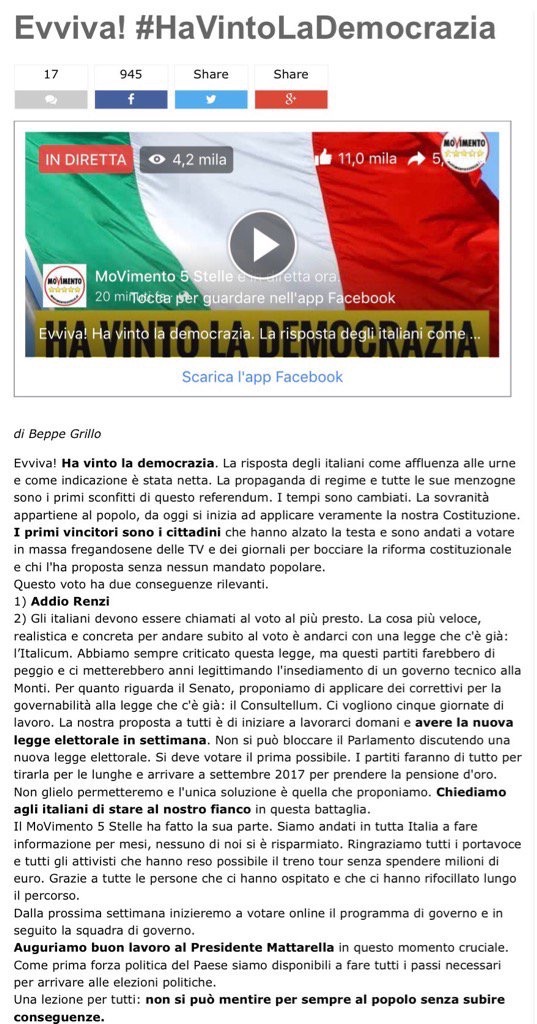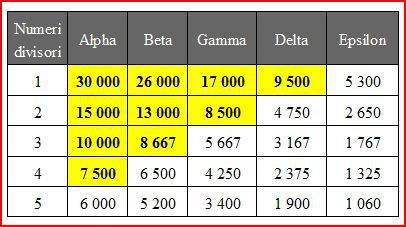Una sconfitta palese e una vittoria implicita
Una sconfitta palese
Il senso di una sconfitta palese è che diventano eroi anche i soldati che portavano le pignatte.
La sconfitta palese è quella subita nel referendum lombardo veneto.
Sia in Veneto che in Lombardia è emersa con forza la volontà delle popolazioni locali di gestire le risorse che genera il territorio direttamente.
Questa è una sconfitta palese dello Stato centrale.
La volontà popolare rinforza i governi regionali lombardo e veneto, che sono già forti di una legittimazione popolare diretta, grazie all’elezione dei loro presidenti, e di una stabilità sostanzialmente di legislatura, grazie alla regola simul stabunt simul cadent.
La forza dei governi locali trova una controparte assai debole: la riforma elettorale attualmente in gestazione non è fatta per creare un indirizzo politico legittimato direttamente dal corpo elettorale, ma per restaurare una forma di governo parlamentare in cui la doppia fiducia e le geometrie variabilmente asimmetriche delle due camere rendono il Capo dello Stato arbitro di equilibri politici instabili e che possono portare a elezioni anticipate con una frequenza d’altri tempi.
E una vittoria implicita
In questo referendum hanno vinto anche i marmittoni.
I marmittoni, in questo caso, sono i quesiti referendari che la Corte costituzionale ha dichiarato incostituzionali con la sentenza 118/2015 perché violavano gli artt. 75, 116 e 119, Cost. nonché con le norme dello Statuto del Veneto che regolano i referendum consultivi.
Questi quesiti suonavano (art. 1, legge reg. Veneto 15/2014):
1) “Vuoi che alla Regione del Veneto siano attribuite ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia?”;
[2) “Vuoi che una percentuale non inferiore all’ottanta per cento dei tributi pagati annualmente dai cittadini veneti all’amministrazione centrale venga utilizzata nel territorio regionale in termini di beni e servizi?”;
3) “Vuoi che la Regione mantenga almeno l’ottanta per cento dei tributi riscossi nel territorio regionale?”;
4) “Vuoi che il gettito derivante dalle fonti di finanziamento della Regione non sia soggetto a vincoli di destinazione?”;
5) “Vuoi che la Regione del Veneto diventi una regione a statuto speciale?”]
L’approvazione dell’unico quesito salvato dalla Corte, sul piano politico, ha il significato dei quattro quesiti che la Corte ha considerato inammissibili perché la maggiore autonomia che Veneto e Lombardia chiedono riguarda essenzialmente il cd. residuo fiscale e quindi una autonomia pressoché costituzionale di queste due regioni.
Il governo della Repubblica difficilmente potrà negare ingresso a questa istanza e dovrà inventare un nuovo tipo di regionalismo.
Ma tutto questo può cadere sulle spalle di un governo fragile come quello che la nuova legge elettorale consegnerà alla prossima legislatura repubblicana?