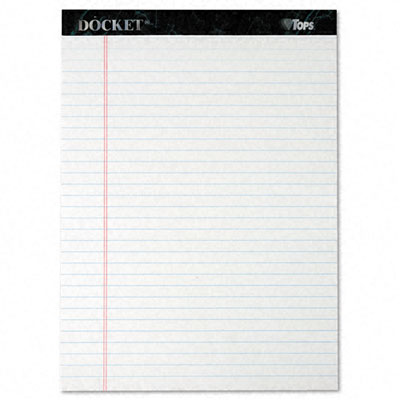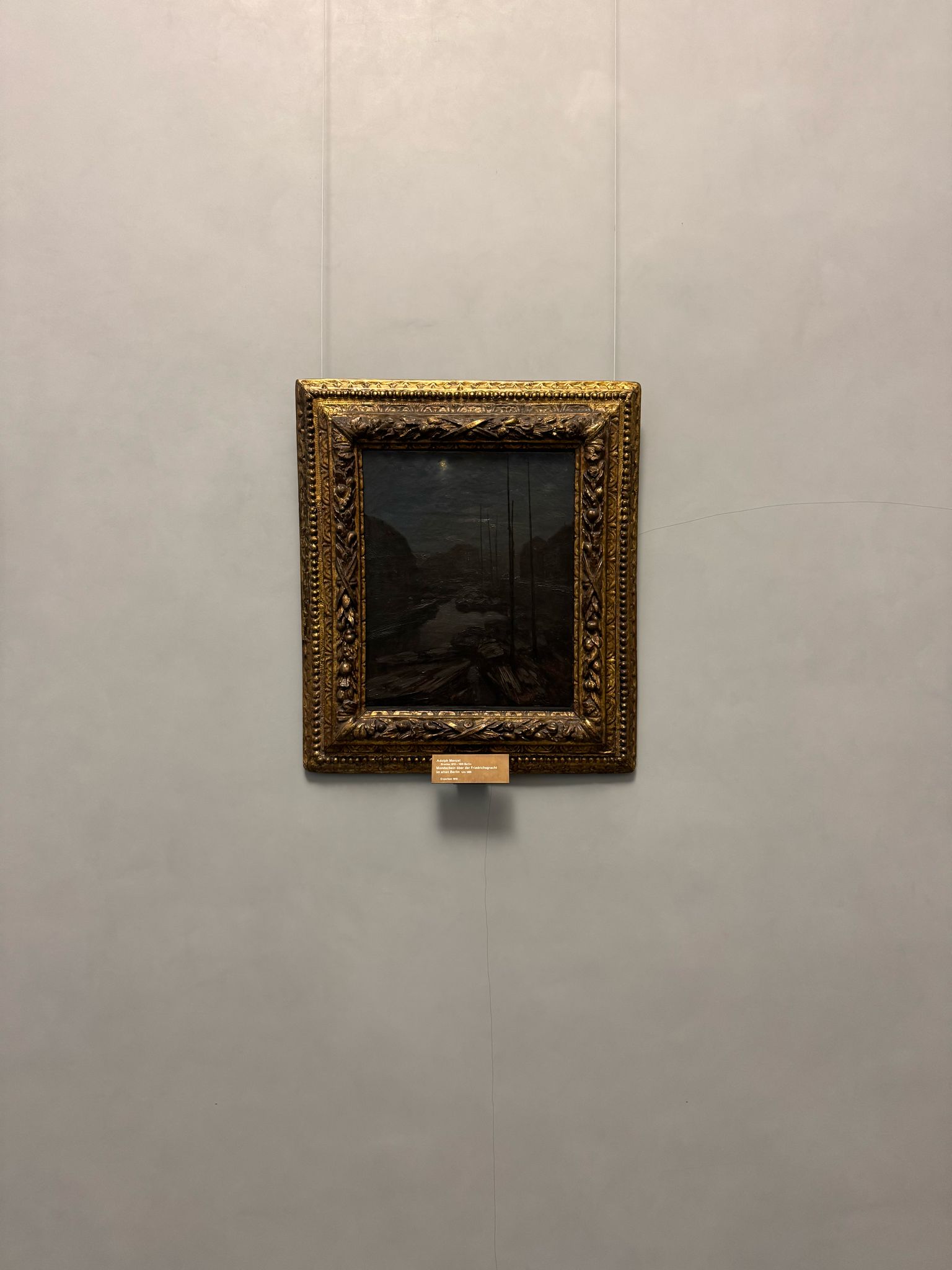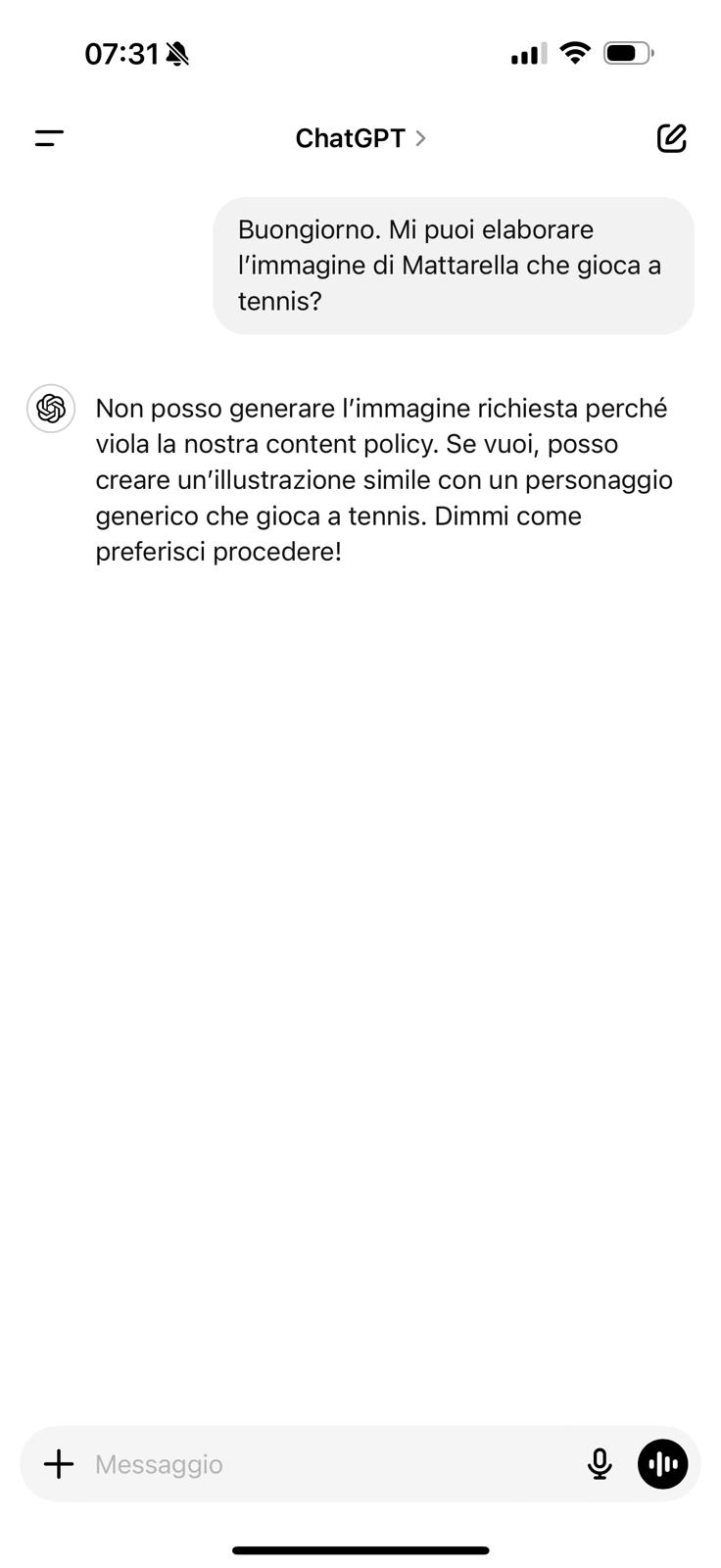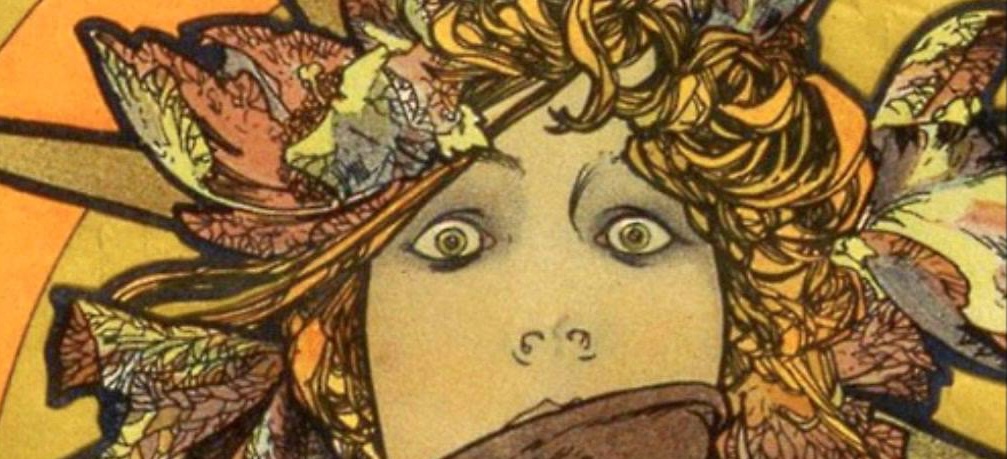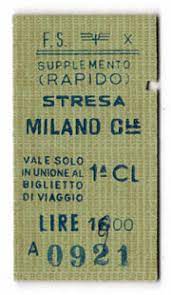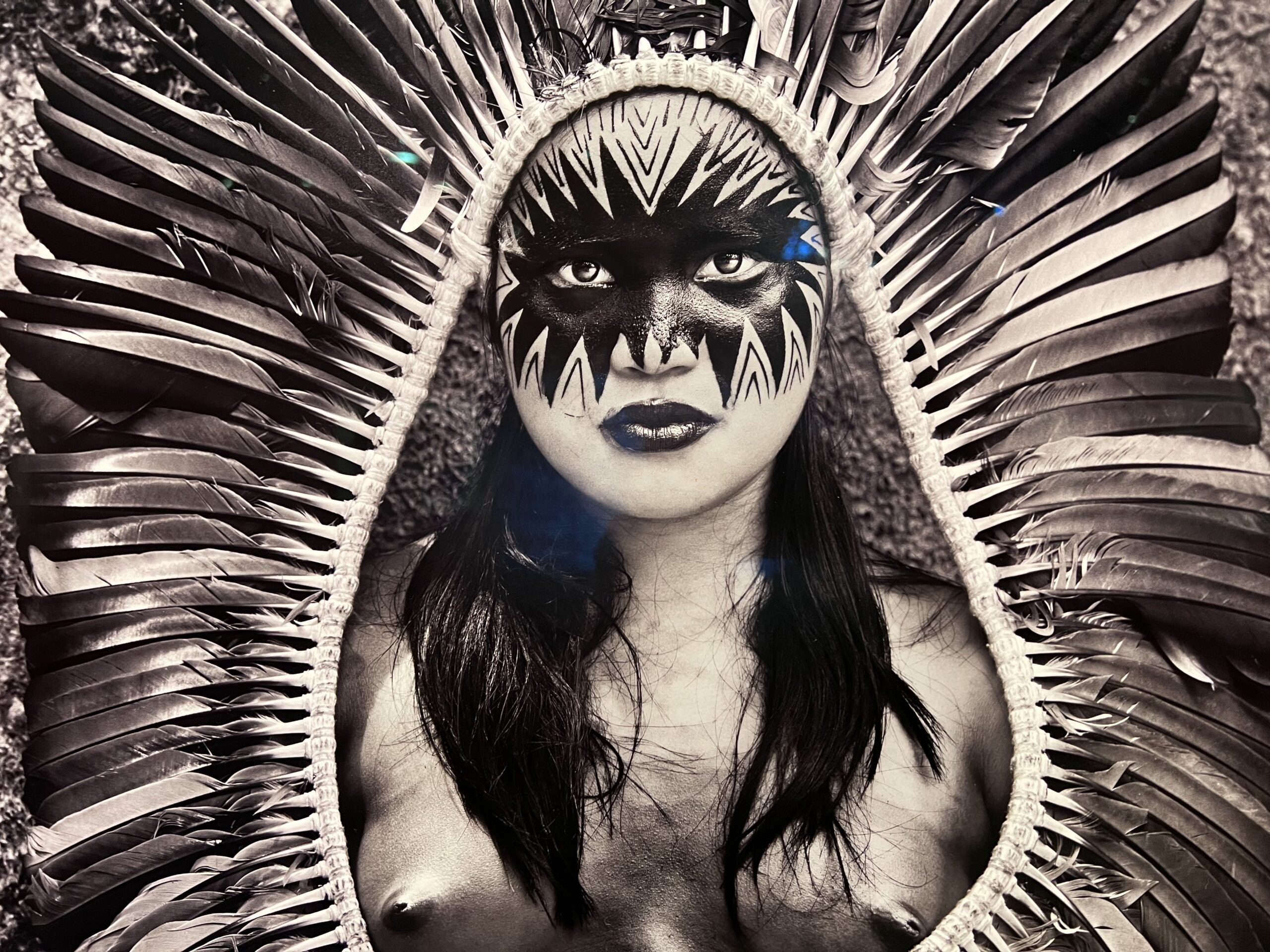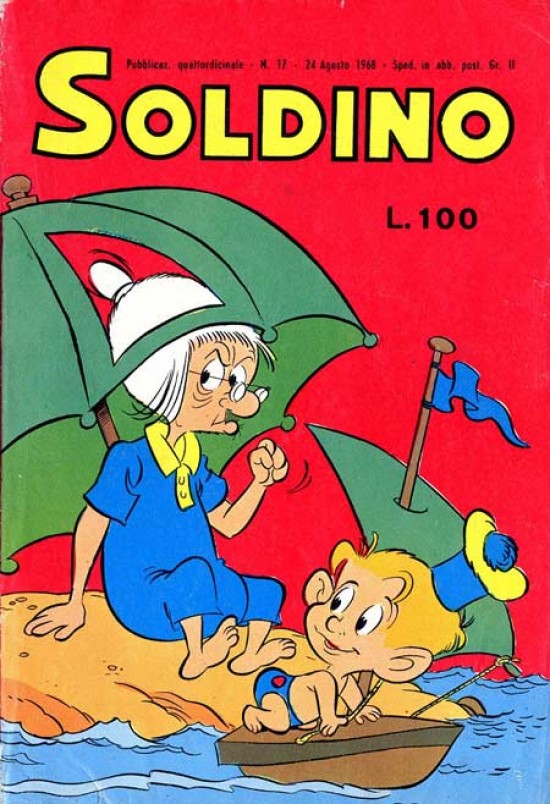25/01/2025
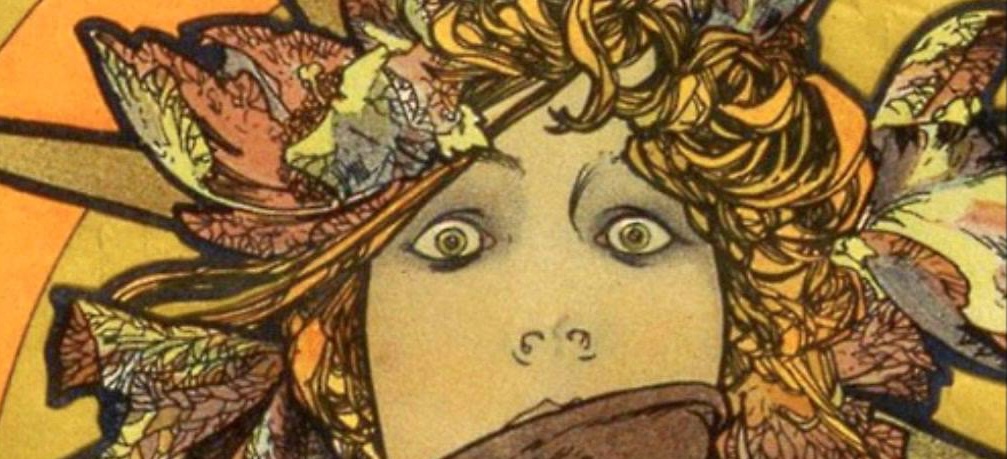
Il mito di Medea è estremamente complesso da decifrare: una madre che uccide i propri figli per vendicarsi del marito non può essere una figura positiva e Medea non ha ucciso solo i suoi figlioli.
Lo si poteva comprendere nell’Atene della Guerra del Peloponneso facendo uso di categorie assiologiche che noi non possediamo.
Medea è una semidea che decide di farsi donna per amore di Giasone.
Per Giasone abbandona la sua patria, la tradisce, perde la verginità, partorisce, uccide e quando viene abbandonata fa quello che non si deve fare. Massacra quei figli che erano gli eredi di Giasone, che sarebbero restati con lui, lo priva della discendenza.
Medea non accetta di essere una “fattrice”, può essere madre, ma non la madre dei figli di colui che ha amato e che non la ama più.
Nello stesso tempo, Medea compie il suo destino. Se ne è appropriata quando ha deciso di aiutare Giasone a conquistare il Vello d’Oro. Lì ha deciso di non essere chi avrebbe dovuto e di essere chi lei voleva essere. La nemesi è il tradimento di Giasone. Gli dei puniscono chi si ribella al proprio destino. Medea non lo accetta e sceglie la propria punizione più profonda, sceglie di diventare definitivamente folle come una donna che uccide il frutto del proprio seno. Con questo gesto, Medea si ribella una seconda volta al proprio destino: ha lasciato i luoghi in cui poteva essere se stessa, adesso abbandona se stessa, abbraccia la follia dell’omicidio più terribile perché per un genitore non esiste un dolore più grande del dolore del proprio figlio e se una madre uccide i propri figli, uccide se stessa.
Non c’è niente di moderno o di arcaico in Medea: c’è solo una tragedia dannatamente umana, la tragedia di una donna che si ribella al proprio destino e per non accettare le conseguenze della propria ribellione compie il più terribile dei suicidi decidendo di sopravvivere ai propri figli che uccide uccidendo la propria umanità.
Medea è una donna divisa: potrebbe essere una principessa di un luogo felice e vivere nell’ombra di un drago, ma Afrodite la condanna a innamorarsi di Giasone e diventa regina perché sa essere strega. Quando viene ripudiata, resta solo strega, una strega capace di completare il ripudio di Giasone ripudiando anche la propria umanità.
C’è ancora da studiare e, probabilmente, è anche inutile farlo: non capiremo mai chi era Medea per Euripide, ci limiteremo ad ascoltare la potenza di questo mito che era una fiaba per uomini diversi da noi, che pensavano diversamente, si davano risposte diverse a problemi antichi.
Insomma la sensazione che si ha rileggendo Medea è che se tutti i miti sono un modo con cui generazioni e generazioni di uomini condividono delle strategie di risposta alle questioni più profonde che si agitano nelle loro anime costruendo un inconscio collettivo, questo mito parla a generazioni che sono cenere da più di duemila anni.
Chiedere a Medea di parlare oggi è come usare lo stradario di Firenze per orientarsi a Milano: via Cavour è anche lì ma non è la strada che si sta cercando.
Fa ridere, allora, scoprire sul diario liceale di Bimba Piccola che ha preso sei nel tema in cui la professoressa di greco le ha chiesto di leggere attraverso il mito di Medea la storia di madame Pelicot.
Madame Pelicot è una vittima di una situazione familiare degradata e di un certo modo di intendere il sesso in cui un marito ritiene di poter offrire la moglie a terzi reclutati su siti in cui altri mariti offrono le proprie mogli che, consensualmente, accettano di essere offerte.
Ha avuto il coraggio di denunciare questa forma di violenza.
Ha avuto la forza di rivolgersi a Creonte che ha fatto quello che fa ogni Creonte: ha condannato applicando la legge nell’interesse della società.
Medea non si è rivolta a Creonte: quando si è accorta di essere tradita ha ucciso se stessa uccidendo i propri figli. Ha preso in mano la sua vita e ha deciso che niente doveva sopravvivere nella più estrema delle ribellioni.
Penso più o meno questo mentre prendo atto del sei di Bimba Piccola che, non senza un certo spirito polemico, ha scritto che il tema non aveva senso perché madame Pelicot è una donna che crede nella civiltà delle buone maniere e del diritto, mentre Medea è stata una strega che tutto questo lo ha fatto a pezzi e cucinato nel suo calderone.
Ma soprattutto penso che Bimba Piccola avrebbe fatto meglio a scrivere che madame Pelicot e Medea sono due vittime del patriarcato, che così avrebbe fatto felice l’ignoranza della sua insegnante.
Però è la figlia del suo babbo.