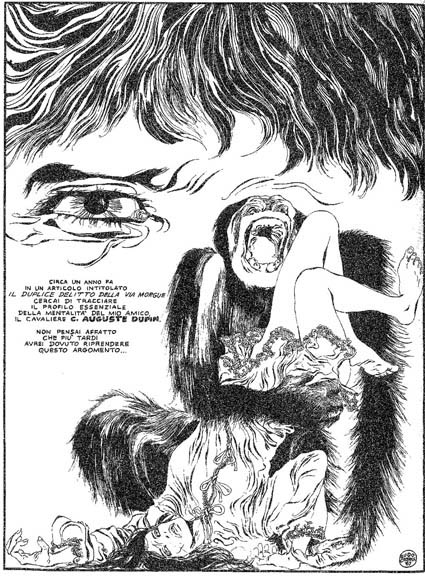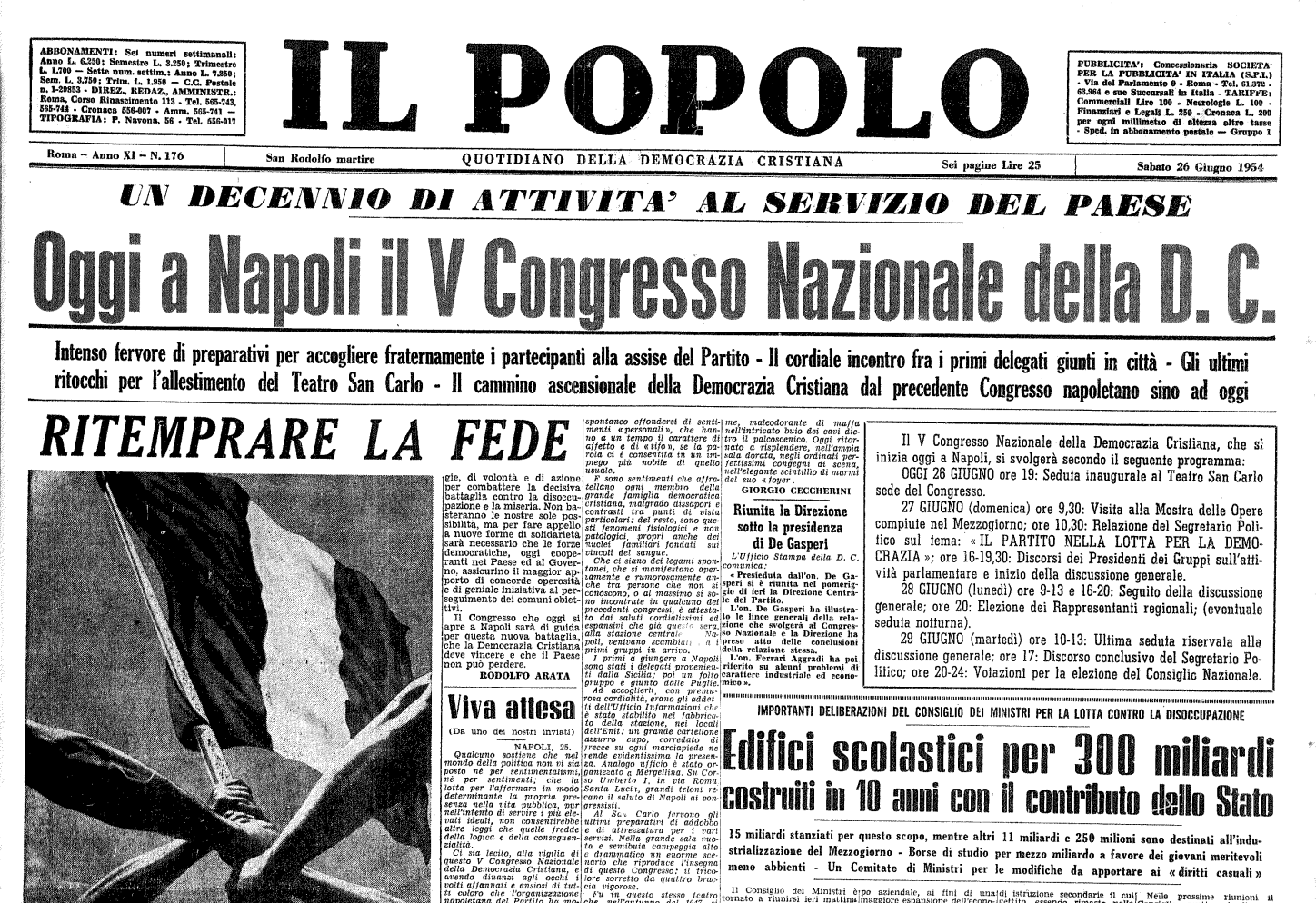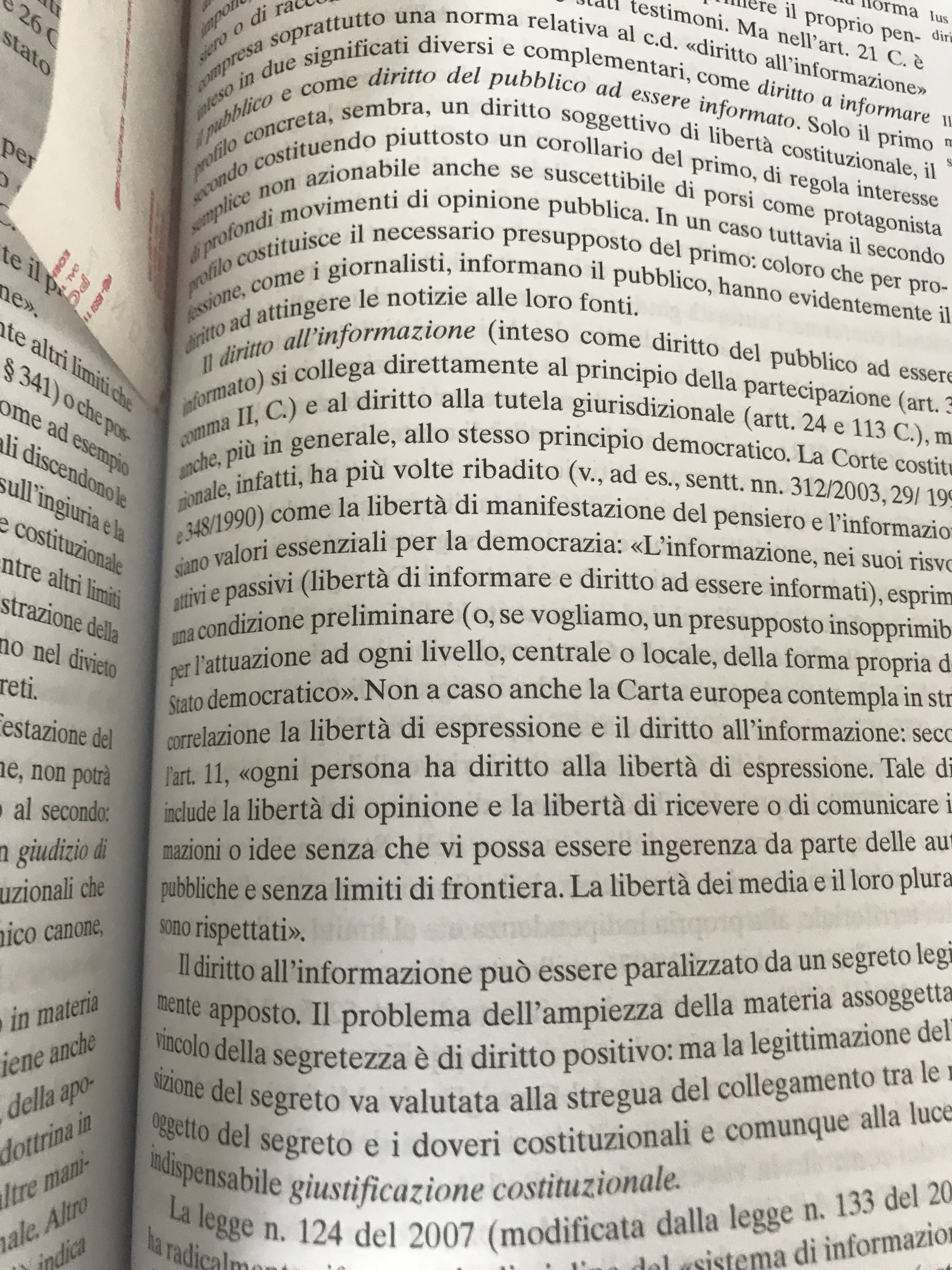Il delitto perfetto
Di Maio ha definito come un delitto perfetto l’aggiudicazione della gara per lo stabilimento di Taranto dell’ex Ilva ad Arcelor Mittal.
Sarebbe un delitto perfetto perché non sarebbe stato tenuto nel dovuto conto l’interesse pubblico al risanamento ambientale ma questa omissione non consentirebbe l’annullamento in via di autotutela della gara.
Il delitto perfetto, il delitto della Rue Morgue sognato da Edgar Allan Poe, è il delitto in cui il colpevole non può essere punito, perché il colpevole non è l’assassino.
Le parti in gioco, il colpevole e l’assassino, sono la politica e l’amministrazione: il livello politico, che è definizione dei valori che consentono di unire le persone in una comunità, e l’amministrazione, che è la trasformazione di questi valori in realtà, per mezzo di imparzialità e buon andamento, rispettando il principio di legalità dell’azione amministrativa.
Per Di Maio, si ha un delitto perfetto perché le regole dell’azione amministrativa impediscono alla politica di tornare sui suoi passi, malgrado vi sia una lesione dell’interesse al risanamento ambientale di Taranto.
Non è un delitto perfetto: è il principio di legalità e sarebbe davvero terribile uno Stato che consentisse al principio di legalità di cambiare di senso ad ogni avvicendamento politico.
Di Maio, però, non parla più di Ilva, sembra essersi arreso, sembra avere trovato nella retorica del delitto perfetto il motivo per giustificare il tradimento di una promessa elettorale piuttosto chiara.
Parla, invece, con lo stesso vigore, della concessione ad Autostrade e urla, insieme al suo ministro Toninelli, a gran voce che questa concessione deve essere revocata e che è il momento di tornare alle nazionalizzazioni.
Anche in questo caso, sembra di poter parlare di un delitto perfetto: perché la revoca della concessione a Autostrade per l’Italia non riguarda il livello della politica – il livello della costruzione dei valori e della comunità – ma il livello amministrativo: dipende dall’analisi della convenzione in essere e dalla comprensione pro veritate della gravità dell’inadempimento commesso dal gestore nel momento in cui il ponte Morandi è crollato.
Ma lo stesso vale anche per il proclama con cui Di Maio affida a Fincantieri l’opera di ricostruzione del ponte, senza considerare che, forse, è la convenzione in essere che regola chi affida i lavori che devono essere svolti e a quali condizioni e che comunque la scelta di un appaltatore non appartiene al livello politico.
Quando si parla di eccesso di potere, si parla anche di confusione fra politica e amministrazione, di un’amministrazione che si lascia condizionare dalla politica e di una politica che vuole scendere al livello dell’amministrazione.
E’ quello che Di Maio lamenta quando parla della gara sulla ex Ilva ed è esattamente quello che Di Maio fa quando parla di Autostrade: il suo ruolo dovrebbe essere di passare le carte all’Avvocatura dello Stato perché definisca le iniziative da intraprendere per tutelare l’interesse nazionale e, in questo, non c’è niente di politico.
C’è un contratto da interpretare.
Distinguere fra colpevoli e assassini è la base dell’eccesso di potere: Di Maio è il colpevole della revoca della concessione a Autostrade, se mai ci sarà, ma non è l’assassino, perché non può essere lui a disporla, deve essere il ministero delle infrastrutture, compiuti i necessari passi e rispettata la legalità procedimentale.
Anticipare a livello politico le scelte amministrative serve solo a precostituire un sintomo di eccesso di potere, ovvero a commettere un delitto perfetto: fingere di revocare, revocare con un provvedimento illegittimo in modo da consentire a Palazzo Spada di annullare la revoca, con buona pace di tutti: della politica che può affermare di avere fatto tutto quello che poteva, persino un provvedimento illegittimo, e delle Autostrade di Atlantia che possono riprendere i loro affari.
Avremmo voluto un mondo diverso, ma avremmo voluto anche un vice premier che non si fa ritrarre dal fotografo di corte dei Benetton (Oliviero Toscani) mentre attacca il loro impero economico, senza accorgersi dell’ironia di quel ritratto.