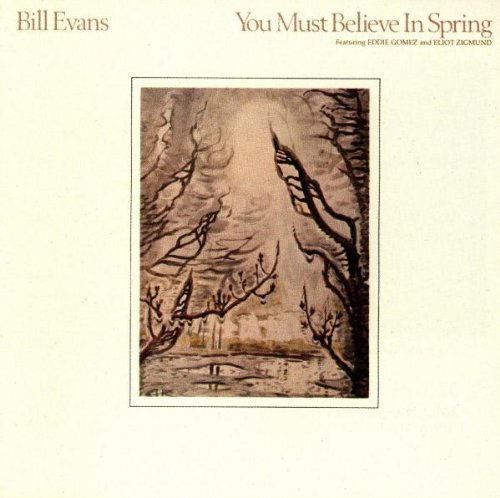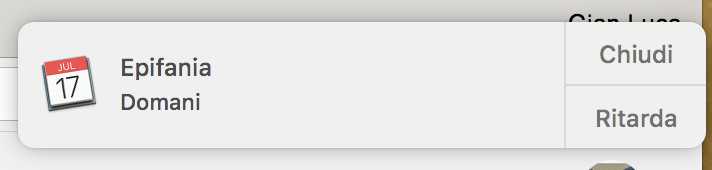17/09/2018

Oggi, il primo giorno di liceo di Bimba Impertinente, non c’ero.
Non ci potevo essere e comunque non sarei stato una presenza gradita.
Non avrò le fotografie di Bimba Impertinente che attraversa il portone del liceo da collazionare con il nido, la materna, le elementari e la scuola media. Mi dispiace.
Io non volevo fare il liceo classico e nemmeno il liceo che ho fatto. Ne avevo paura. Avevo paura di non riuscirci, di non essere all’altezza.
Ho imparato ad amare questo liceo giorno per giorno, versione per versione, senza mai sentirmi davvero all’altezza delle cose che stavo studiando, dei temi che mi venivano proposti.
Poi mi sono trovato tante volte a spiegare perché quei cinque anni passati a sudare la Germania di Tacito e riflettere sul motore immobile di Aristotele erano stati per tutti noi così importanti.
Sono due gli argomenti che spesso ho utilizzato.
Il primo è che al liceo classico, non si impara a far di conto. La matematica è soffocata dal latino e dal greco e questo può disturbare molto chi crede nella importanza dei numeri e di saper far di conto più velocemente della persona con cui fa affari facendo le vesti di conversare.
La mia società conta spesso, l’essenziale è quasi sempre un numero e quel numero è il punto di arrivo di un algoritmo solo apparentemente matematico, come il prezzo di un’opzione su un mercato non regolamentato.
Al liceo classico, si impara che i numeri sono meno importanti delle parole, non sono niente senza lo sforzo di capire che è proprio di chi cerca il significato delle parole e le parole contengono le persone.
Il secondo argomento è legato alla specificità del latino e del greco. Le lingue hanno sempre una loro specificità che deriva dalla funzione che hanno assolto. L’inglese è una bellissima lingua di connessione, la cui eleganza è la semplicità. Il francese è diplomatica poesia. Il tedesco, precisione di medici, ingegneri e filologi. L’italiano è una lingua di ricordi, serve per raccontare un paesaggio mentre sta scomparendo.
Il latino ed il greco, invece, sono lingue morte, che si conoscono non per come erano parlate da un mercante della Beozia o da un mercenario di Brutium, ma per come furono parlate da poeti talmente raffinati e profondi da resistere alle notti barbare.
Di una parola greca o latina, noi non conosciamo il significato quotidiano ma solo quello che ha avuto nella lingua scritta di uomini dalla sensibilità eccezionale, capaci di raccontare il discorso di un guerriero all’oceano dell’eternità e di esprimere con una sola parola la potenza di una persona nell’attimo in cui stava diventando polvere.
Ho pensato a questo oggi che era il primo giorno di liceo di Bimba Impertinente e non glielo ho detto perché sono cose che si capiscono solo se si capiscono da soli.
A lei, ho detto solo che anche sul mio banco qualcuno aveva inciso con una chiave la frase “Dio aiutami”, che ha trovato incisa sul banco della sua classe e che mi ha fatto ricordare l’angoscia delle versioni prima di trovare il bandolo della matassa.
Perché il liceo è anche saper dialogare con quell’angoscia, senza la quale, forse, non s’impara molto.